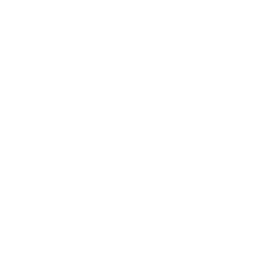Siamo sorprendentemente arrivati al ventesimo numero di questa rivista e abbiamo dunque alle spalle un ventennio di attività e di presenza (soprattutto online), che ci ha permesso di essere spesso ricordati negli studi di settore al di là del nostro peso effettivo. Abbiamo perciò creduto necessario riflettere non tanto sulla nostra esperienza, in fondo non particolarmente significativa, quanto sul mare di pubblicazioni periodiche che in questi anni sono state dedicate ai fenomeni migratori, spesso riportando i più recenti risultati della ricerca.
Al contrario di quanto molti studiosi delle migrazioni sostengono il nostro ramo specifico non soffre di una scarsità di pubblicazioni. In tutto questo secolo libri e riviste dedicati agli studi migratori sono stati numerosissimi, sia nel nostro paese, sia nel resto del mondo. Però, e questo è il punto dolente, non sono stati particolarmente letti dagli studiosi di altri settori, come anche da quelli del nostro, se non per quanto messo sul web. Proprio per questo una rivista come la nostra, venduta via internet e soprattutto sin dagli inizi in gran parte disponibile gratuitamente online, è di sovente citata più di consorelle maggiormente blasonate.
Partiti da questa constatazione, che si lega al discorso sulla trasformazione dei modi di leggere[1], cui si potrebbe aggiungere la lamentatio, sempre in progress, sulle deficienze attuali e passate del mondo e della cultura accademica [2], ci siamo domandati come perimetrare l’editoria sulle migrazioni. Abbiamo quasi subito deciso di non prendere in considerazione i libri, perché sono troppi: si consideri che alla fine di novembre su amazon.it alla sola query “emigrazione” erano elencati più di 9.000 titoli in vendita. Ci siamo invece concentrati sulle riviste, anche perché lavorando in vari centri studi sui fenomeni migratori abbiamo visto negli anni aumentare il loro numero. Abbiamo voluto dunque vedere quante e come siano e non soltanto in relazione ai movimenti da e nella Penisola. Abbiamo quindi iniziato a valutare la letteratura periodica di tutti i continenti, grazie al valido aiuto di un folto gruppo di studiosi e studiose. Ci siamo inoltre chiesti come e perché tutti questi trimestrali, quadrimestrali e bollettini siano nati e abbiano prosperato. E abbiamo concluso che hanno raccolto finanziamenti e quindi continuato a vivere grazie alla crescente attenzione ai fenomeni migratori, purtroppo troppo spesso intesi come lo strumento che porterà alla dissoluzione del nostro mondo occidentale.
Per molti anni la presenza di riviste specialistiche è in effetti dipesa dall’impatto delle migrazioni sul passato e il presente del Paese nel quale erano edite. L’essere il riflesso di una situazione sociale e politica specifica ha portato all’inizio a porre l’enfasi sulla distinzione tra emigrazione e immigrazione. La globalizzazione del terzo millennio ha, però, dato il colpo di grazia ai prefissi, lasciando il passo allo studio di soggetti mobili che emigrano e immigrano con una fluidità incontrollabile e in termini spesso drammatici per modalità ed entità. Abbiamo così scoperto che ognuno ha il suo sud e il suo nord: molti Paesi dell’America Latina come il Brasile e il Venezuela e molti Paesi europei (basti pensare al nostro), accogliendo milioni di persone, sono divenuti ad un tempo Paesi di emigrazione e di immigrazione. Nel caso del Brasile si devono considerare allo stesso tempo gli oltre quattro milioni di brasiliani che risiedono all’estero e l’aumento dei flussi in entrata da regioni africane, nonché il numero di rifugiati in conseguenza di disastri naturali o a causa di conflitti o dittature (si pensi agli haitiani che hanno esperito entrambe queste cause di diaspora. Si è allargato così il focus delle analisi. Nel Brasile, in particolare, ci ricorda de Ruggiero in questo nostro fascicolo, “i numerosi articoli relativi a questioni migratorie sono distribuiti in una miriade di riviste, perlopiù legate ai principali dipartimenti universitari di storia e scienze umane, che spaziano dalle questioni sociali ed economiche, a quelle politiche e culturali”.
In altri Paesi si ha invece un parziale calo di interesse per la questione migratoria, come segnalano Alicia Bernasconi e Federica Bertagna esaminando il caso dell’Argentina, dove “si può dire in parte esaurita la stessa riflessione sul ruolo che [le migrazioni] hanno avuto nella storia del Paese”. Anche se oggi l’ottica “nazionale” riscuote meno interesse nello studio delle migrazioni, continua tuttavia ad avere un impatto sulle politiche di molte nazioni, per cui alla fine i ricercatori proseguono ad affrontarla sia a livello locale che globale, pur avendo sempre presenti anche le problematiche internazionali [3].
Questo numero dedicato alle riviste delle migrazioni inizia, non a caso, con una rassegna riguardante gli Stati Uniti, in cui per prima si è sviluppata la sociologia dei fenomeni migratori all’inizio del Novecento. Inoltre sempre gli Stati Uniti si sono trovati ad affrontare per primi, nel secondo dopoguerra, il dibattito sull’inclusione culturale delle minoranze etniche. Discussione che ha portato all’affermazione del concetto di pluriculturalismo in molte società occidentali. Negli anni sessanta, a fronte della crisi scatenata dal perdurare del conflitto nel Vietnam e dalle rivolte per i diritti civili, il governo statunitense tentò di conquistare il consenso di più ampie fasce sociali attraverso una rivalutazione dell’“etnia”, accettando le istanze degli stessi gruppi immigrati. La via più sicura per il rafforzamento della società statunitense passò attraverso il rinvigorimento delle diverse identità culturali. L’elemento “etnico” divenne quindi un fattore per avanzare richieste al governo che si concretizzò con l’adozione delle azioni positive. Sull’onda del successo dei neri nell’ottenere l’introduzione dei Black Studies nelle università americane, anche altre minoranze riuscirono a fare introdurre nei curricula universitari discipline che si occupavano specificamente di migrazioni ed etnicità. Per questo probabilmente gli Stati Uniti sono il Paese in cui ancora oggi trovano spazio numerose riviste “etniche”, tra cui campeggiano quelle “italiane” con vario indirizzo disciplinare. Nate a partire dagli anni sessanta sono la sede privilegiata in cui si è gradualmente sviluppato il confronto tra gli studiosi dei vari Paesi superando nel tempo una sorta di divisione del lavoro tra chi, in Italia, si occupava di emigrazione, guardando soprattutto all’aspetto economico e all’impatto del fenomeno sul territorio, e chi, all’estero, si dedicava prevalentemente allo studio delle modalità di integrazione degli immigrati.
In questa, seppur necessariamente incompleta, rassegna Italia e Stati Uniti sono i due Paesi in cui sono presenti riviste dedicate specificatamente alle migrazioni italiane. Inoltre tali riviste sono accompagnate da una galassia di bollettini e newsletter. Ad esempio, nell’Archivio del Centro Altreitalie di Torino, che opera nel campo delle migrazioni dagli anni ottanta del secolo scorso, sono raccolte 33 testate di riviste e un’ottantina di titoli di bollettini, questi ultimi dedicati prevalentemente alle migrazioni italiane in vari paesi del mondo. Altrettanto numerose sono le testate e i bollettini disponibili nella biblioteca del Centro Studi Emigrazione di Roma, aperto nel 1963 per seguire la diaspora italiana e oggi attento a tutte le forme di mobilità fra e nei vari continenti. Grazie a queste due istituzioni, possiamo dunque notare, come segnala Donato Di Sanzo nel contributo a questo fascicolo, “la crescita degli studi sul tema […] ha prodotto sia un’evoluzione dell’attività dei periodici più tradizionalmente specialistici, sia l’aumento di interventi e contributi presenti in contesti generalisti”.
La Spagna, come l’Italia, ha avuto cambiamenti repentini da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione, sia dall’America Latina che, dopo Schengen, dall’Europa. In Spagna, Portogallo, Francia le migrazioni sono inoltre state influenzate dal passato coloniale, purtroppo non ancora sufficientemente esplorato e troppo spesso depurato del suo côté migratorio (in genere duplice: dalla madrepatria alle colonie e viceversa). In Francia oggi molte riviste, nelle discipline delle scienze umane e sociali, dedicano finalmente numeri tematici alle questioni migratorie legate ai flussi vecchi e nuovi dal Nord Africa, ma poche trattano delle partenze francesi nel presente e nel passato. Una rimozione analoga a quanto accade nel Québec, dove gli arrivi di oggi rischiano di far dimenticare la diaspora di ieri verso i vicini e più ricchi Stati Uniti.
In Francia, come in altre nazioni europee (si pensi al Regno Unito o alla Germania in questo fascicolo affrontate nei dettagli), le riviste che trattano delle migrazioni nel loro complesso sono antiche, alcune risalgono addirittura agli anni cinquanta del secolo scorso. Oltre al loro carattere interdisciplinare, che riflette le trasformazioni della ricerca, questi periodici palesano le odierne preoccupazioni riguardo alle migrazioni internazionali. Inoltre la situazione dei rifugiati, la secolarizzazione e la decolonizzazione generano una nuova sensibilizzazione verso le questioni dei diritti umani e dell’accoglienza.
Le riviste tedesche sulle migrazioni riflettono le fasi dei processi migratori più recenti e, come nota Edith Pichler in questo fascicolo, hanno approfondito argomenti giuridici negli anni sessanta e le cause economiche e sociali della mobilità alla fine di quel decennio e in quello successivo. Dopo i ricongiungimenti familiari dell’ultimo quarto del secolo, sono emersi gli studi di carattere pedagogico incentrati sulle seconde generazioni immigrate e l’analisi dell’assistenza sociale. In maniera analoga, il dibattito accademico e le pubblicazioni scientifiche in Scandinavia hanno seguito l’evoluzione politica locale, analizzando la tradizione d’accoglienza una volta imperante, almeno in apparenza, e il suo declino.
La scansione temporale della nascita delle riviste è dettata dai grandi avvenimenti contemporanei anche per i paesi dell’Europa nord e sud-orientale dove, con l’apertura delle frontiere negli anni novanta sono riprese le migrazioni. La Romania negli ultimi 30 anni ha visto la partenza di 4 milioni di persone, inoltre, segnala Antonio Ricci: “[i]n un paese che conta 20 minoranze nazionali riconosciute […] è stato necessario promuovere un approccio in grado di integrare gli studi sulle migrazioni con gli studi sulle minoranze etniche, […] che si rispecchia nella diversificazione della produzione di articoli su riviste scientifiche di diverso indirizzo interdisciplinare”. In Slovenia negli anni novanta è fondata “Two Homelands” per rispondere all’esigenza di studi e documentazioni sulle esperienze degli emigranti sloveni in tutto il mondo e sull’identità nella diaspora.
Senza indugiare oltre in un’analisi dettagliata dei singoli contributi, possiamo notare come nella produzione sulle migrazioni facciano da padrone le riviste in lingua inglese, anche perché molte sono prodotte o distribuite da grandi circuiti editoriali-accademici che vorrebbero monopolizzare tutto il settore, offrendo anche una sponda a quanto prodotto negli altri continenti, soprattutto in Asia e Oceania. Certo nell’affrontare questi ampi spazi geografici ed editoriali siamo stati un po’ sbrigativi, badando meno al particolare di quanto abbiamo fatto per le due Americhe e per l’Europa. Però, bisogna riconoscere che siamo comunque riusciti a toccare tutte le aree continentali, pur se badando quasi esclusivamente alle riviste in inglese, francese e spagnolo. Molto resterebbe da fare, soprattutto bisognerebbe esplorare le pubblicazioni in altre lingue. Queste infatti porterebbero ulteriori elementi per studiare continenti come l’Africa e l’Asia dai quali partono enormi flussi verso i luoghi tradizionali di immigrazione (Stati Uniti e Canada, Australia e Nuova Zelanda) e nei quali si intrecciano importanti sottosistemi migratori. Si pensi per l’Asia a quello orientato verso il nordest continentale e a quello formato dai flussi da e verso il sudest, senza dimenticare le migrazioni nei paesi dell’Asia centrale, i flussi da e verso il subcontinente indiano e quanto accade nel grande polo mediorientale, in particolare i paesi del Golfo.
Ricordare quanto dobbiamo ancora affrontare per capire queste realtà ci porta a recuperare un caveat suggerito da Monica Miscali in questo fascicolo. La produzione scientifica di molte nazioni occidentali è oggi dominata da una sorta di distorsione accademica, frutto dei monopoli editoriali cui prima si accennava. Per ragioni di valutazioni accademiche, necessarie alla carriera dei ricercatori, si indugia troppo in una sorta di discussione transnazionale (per altro sempre inanemente incentrata sull’Occidente) e si trascura la ricerca locale, pur quando riguarda interi continenti, quali appunto l’Africa e l’Asia. Per questo sono interessanti esperimenti quali quelli dei centri studio e delle riviste scalabriniane che programmaticamente si pongono dalla prospettiva locale e cercano di far emergere quanto sta accadendo oggi e quanto è accaduto nel passato in un certo numero di realtà nazionali e continentali.
Al di là della nostra incapacità di spingere la ricerca sulle riviste “migratorie” più avanti, anche per la mancanza di effettivi, il nostro lavoro evidenzia che sulle migrazioni si è scritto tanto, seppure anche troppo spesso senza un criterio preciso o soltanto per raccogliere finanziamenti oppure per guadagnarsi avanzamenti di carriera. Resterebbe l’altra domanda, quella sottintesa all’inizio: perché se tanto si è scritto, così poco è stato percepito al di fuori della stretta cerchia dei ricercatori e delle ricercatrici? Qui, però, si entrerebbe in una dimensione diversa e bisognerebbe interrogarsi su come università ed enti di ricerca siano con il tempo divenuti monadi incapaci di comunicare con l’esterno e come quest’ultimo si sia comunque parcellizzato in una serie di realtà che molto spesso non dialogano fra loro. A causa di tale frammentazione e di tale mancanza di comunicazione le riviste qui analizzate non riescono a divenire quello che potrebbero essere, ovvero utili strumenti per elaborare una storia pubblica in grado di abbattere gli stereotipi che continuano a circolare sulle questioni migratorie.
[1] Alcuni anni fa Gino Roncaglia gli ha dedicato un libro purtroppo non letto dagli storici: L’età della frammentazione. Cultura del libro e scuola digitale, Roma-Bari, Laterza, 2018.
[2] Per quanto accaduto da noi: Marco De Nicolò, Formazione. Una questione nazionale, Roma-Bari, Laterza, 2020.
[3] Vedi, da un lato, The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe, a cura di Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour e Lyubov Zhyznomirska, London, Routledge, 2019, e State Policies and Migration. Studies in Latin America and the Caribbean, a cura di Peter Peek e Guy Standing, London, Routledge, 2023; dall’altro, Antoine Pécoud, Depoliticising Migration: Global Governance and International Migration Narratives, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, nonché International Organisations and the Politics of Migration, a cura di Id. e Martin Geiger, London, Routledge, 2015.