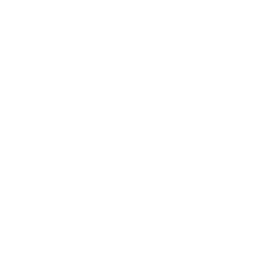Le riviste dedicate specificamente allo studio delle migrazioni in Asia sono soltanto due: “Asian and Pacific Migration Journal” (APMJ) e “Migration and Development”. La prima è stata fondata nel 1992 ed è stata prodotta fino al 2014 direttamente dallo Scalabrini Migration Center, collocato nell’area metropolitana di Manila. La rivista è “peer reviewed” ed è stata iniziata proprio per dare la possibilità a studiosi dell’Asia di interloquire sulla realtà delle migrazioni, così rilevante in quel continente. L’Asia, infatti, non è soltanto l’origine primaria delle migrazioni verso i paesi tradizionali di immigrazione (Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda). È anche un continente con vari sottosistemi migratori, in particolare quello orientato verso il nordest asiatico, quello formato dai flussi da e verso il sudest asiatico, la migrazione nei paesi dell’Asia centrale, i flussi da e verso il subcontinente indiano e il grando polo del Medio Oriente, in particolare i paesi del Golfo. Molta analisi della migrazione in Asia era condotta da studiosi del mondo occidentale. Era ora di dare voce anche agli studiosi autoctoni.
La rivista, con frequenza trimestrale, ha osservato lo sviluppo migratorio nella regione, con particolare attenzione ai lavoratori migranti. Nella valutazione fatta nel 2016, a 25 anni dall’inizio delle pubblicazioni, emergeva che la copertura regionale era disomogenea: la maggioranza degli articoli riguardavano la migrazione verso il nordest e sudest asiatico, meno verso il sud e il Medio Oriente, mentre la migrazione nell’Asia centrale era ignorata. Per quanto riguarda le discipline, c’è stato un aumento della interdisciplinarità, dal momento che agli economisti, ai demografi e ai sociologi si sono aggiunti collaboratori provenienti dall’antropologia, dalla psicologia, dalle scienze politiche e alcuni dal lavoro sociale. Sono anche aumentati i contributi di natura qualitativa, rispetto alle analisi quantitative.
Oltre alla pubblicazione di articoli singoli, sono stati offerti spesso numeri tematici, spesso il risultato di conferenze su argomenti di particolare interesse. La tendenza da qualche anno è di ricevere molti contributi dalla Cina e dalla Corea del Sud. Gli studiosi dalla Cina tendono a proporre articoli soprattutto sulla migrazione interna in quel paese. La Corea del Sud è diventata un importante sbocco migratorio, dove il governo ha adottato una politica cosiddetta multiculturale per facilitare l’inserimento dei migranti, in particolare delle spose di provenienza soprattutto dal Vietnam, dalla Tailandia e dalle Filippine.
Particolare attenzione è stata data alle conseguenze della migrazione sulle famiglie rimaste in patria, in particolare i bambini. In genere gli articoli coprono le varie tematiche legate alle migrazioni, con particolare attenzione alle politiche migratorie che vengono adottate. La migrazione irregolare è molto rilevante nella regione e non ha ricevuto tutta l’attenzione che meriterebbe anche perché confusa spesso con la tratta di migranti, che invece ha ricevuto molta attenzione dato l’interesse politico, e quindi i finanziamenti per la ricerca, da parte dei paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti.
Come altre riviste basate sul sistema del “peer review”, APMJ soffre la difficoltà di trovare revisori disposti a leggere e commentare gli articoli. Sono in considerevole aumento gli articoli che vengono inviati ad APMJ e un primo stadio di revisione viene fatto all’interno, per non appesantire il sistema di revisione con articoli che mancano dei requisiti fondamentali per essere pubblicati. Essendo la rivista pubblicata in inglese, considerevole lavoro deve essere dato anche al perfezionamento linguistico degli articoli, dal momento che spesso vengono scritti da studiosi che non sono di madrelingua inglese.
Non è facile valutare l’impatto della rivista sulla società e la politica di emigrazione. Da un lato, APMJ è una rivista di natura accademica, letta e apprezzata soprattutto nell’ambiente accademico. Dall’altro lato, il mondo politico, pure interessato a produrre politiche che siano basate sull’evidenza, non fa molto uso di riviste scientifiche. La traduzione di quanto prodotto dagli studiosi in materiale fruibile per la trasformazione della società rimane un tema di complicata gestione.
Dal 2014 la rivista è pubblicata da SAGE (sul cui sito è ora disponibile: https://journals.sagepub.com/loi/AMJ), un passaggio ritenuto essenziale per assicurare il marketing e la distribuzione in un contesto sempre più competitivo e per trarre vantaggio degli sviluppi della tecnologia. Gli studenti domandano sempre di più l’accesso alle riviste scientifiche direttamente sul loro computer e soltanto le grandi case editrici possono assicurare questo servizio in modo conveniente. Se SAGE assicura distribuzione e marketing, lo Scalabrini Migration Center continua però ad essere totalmente responsabile dei contenuti.
“Migration and Development” è una rivista che ha iniziato la sua produzione nel 2012 nel Center for Development Studies del Kerala, India, una regione fortemente caratterizzata dalle migrazioni. Dal Kerala infatti molti migranti indiani si recano a lavorare nei paesi del Golfo. La rivista è pubblicata da Taylor and Francis. Unendo il binomio di migrazione e sviluppo, la rivista si è data ampiezza e libertà nella trattazione degli argomenti. Pur essendo collocata in Asia, ospita contributi anche di altre regioni e soprattutto pubblica saggi anche sugli altri continenti: ad esempio l’ultimo contributo del 2022 contiene articoli sui flussi dal Bangladesh alla Malaysia e sui movimenti interni all’India, ma anche sul Messico, l’arrivo di gambiani e i problemi interculturali in Germania, gli studenti palestinesi in Russia. Vengono prodotti tre numeri all’anno, ma attualmente la rivista sembra in ritardo con le pubblicazioni, a causa del recente passaggio dalla distribuzione tramite Taylor & Francis (i numeri dal primo del 2012 all’ultimo del 2022, sono parzialmente disponibili a https://www.tandfonline.com/loi/rmad20) a quella dell’International Institute of Migration and Development, erede del succitato Center indiano. Alcuni nuovi articoli sono, però, già online sul sito dell’Istituto (https://iimad.org/publications/).